
Vita di città
Le alterne vicende di Sovereto e della sua Icona: l'analisi di Vito Bernardi
Uno scritto che ripercorre storicamente uno dei più affascinanti interrogativi riferiti al culto della Vergine
Terlizzi - giovedì 1 maggio 2025
10.39
Dedico questo lavoro al compianto don Michele Cipriani, già Arciprete emerito della Concattedrale di Terlizzi, che per quarant'anni è stato il vigile custode della Icona soveretana nonché autore nel 1992 dell'inno alla Vergine, riportato in calce, musicato nello stesso anno dal Maestro Giuseppe Domenico Binetti.
Parlare di Sovereto significa inserire questo lembo di terra nell'ambito del paesaggio naturale terlizzese che nel corso dei millenni ha subito una radicale trasformazione a causa di eventi di natura geologica e climatica. Con il Neolitico il territorio si trasforma, presentandosi dolcemente poggiante sulla fascia media murgiana, ondulato e ricoperto di macchia mediterranea e con un clima salubre per la vicinanza al mare. Un territorio che sul principio del secolo VIII assumerà un carattere ben definito, tipicamente militare e agricolo secondo lo schema romano germanico. Il Chronicon Monasterii Cassinensis di Leone Ostiense(Vescovo Cardinale di Ostia,1060 circa-1115) parla di un "casale… in Trelicio" che si affaccia alla storia quale possedimento longobardo nel 773, inserito nell'ambito della circoscrizione territoriale di Giovinazzo. La relativa testimonianza documentale è costituita da un atto di donazione del casale, avvenuta probabilmente tra il 778 e il 797, da parte di un gastaldo longobardo del Ducato di Benevento di nome Wacco a beneficio del monastero di Montecassino. Intorno alla metà del sec. XI si affacciano nel Meridione i Normanni con i quali nasce e si consolida il feudalesimo. Troviamo i normanni nel locus Tillizo intorno al 1040 con il terzogenito di Tancredi d'Altavilla, Umfredo, il quale ricostruisce in loco Cisani una chiesa fatiscente(1055).Con il primo feudatario di Terlizzi, il conte Amico, il locus Tillizo acquista autonomia civile ed ecclesiastica dalla vicina Giovinazzo, trasformandosi in castrum con mura, torri, castello, chiesa matrice di S. Angelo e nel 1133 in "civitas Terlitii", aggregata da Ruggero II "rex Siciliae atque Italiae" alla contea di Conversano. Con Guglielmo II, detto il Buono(1166-1189), Terlizzi ritorna contea assumendo una propria identità politica, sociale, economica e religiosa. Nel 1189 Guglielmo II muore e indica suo successore Enrico VI di Svevia. Inizia la monarchia sveva. Nel 1197 muore Enrico VI e lascia erede il figlio Federico II. Federico affida Terlizzi ad Andrea , logoteta del regno di Sicilia, che amplia le fortificazioni attorno la città, potenzia il castello normanno e contribuisce alla costruzione dell'antico duomo romanico gotico. I documenti medievali conservati nel nostro Archivio Capitolare ci aprono orizzonti per comprendere il rapporto simbiotico che intercorre tra il lembo di terra del boscoso Sovero e le vicende politiche e umane della civitas Terlitii che dalla fine del sec. XI fino al XIII costruirà la sua storia feudale rimasta tale fino al sec. XVIII. Suberitum , piccola località poco distante dalla civitas, assunta alle cronache della notorietà per avvenimenti di natura religiosa e sociale ivi avvenuti, in passato era ricoperta da un bosco ricco di querce della varietà suberosa che uno studioso di botanica, il francescano cappuccino Antonio Amico, in religione Padre Rosario, la individua nell' "Ulmus campestris". Difatti osserva: "Può darsi che la varietas suberosa fosse anticamente frammista alla specie tipica e che dal popolo venisse chiamata sughero(suber)". Il documento più antico che parla del bosco di Santa Maria di Sovereto, denominato anche bosco di San Marco o Parco Forte, è del 1183.Nel 1294 l'Università' di Terlizzi lo acquistò e dette la possibilità ai propri cittadini di legnare e pascolare e quindi di godere degli usi civici su quelle terre in perpetuo. Il toponimo Suberitum per la prima volta viene citato nella bolla dell'arcivescovo Angelo di Bari del 1131 il quale concedeva pieni poteri giurisdizionali al vescovo Ursone su Giovinazzo e Terlizzi e relative pertinenze, fra cui Suberitum. Un 'altra Bolla del 1172, dell'arcivescovo Rainaldo di Bari, rinnovava al vescovo Berto di Giovinazzo antichi e nuovi privilegi:"(…)cum omnibus monasteriis virorum seu feminarum, grecis aut latinis, intus in civitatem(…)vel de foris". Antichi e nuovi privilegi si riferivano agli insediamenti urbani o monastici con una ecclesia sui quali si esercitavano poteri giurisdizionali. Prima della bolla del 1131 dell'arcivescovo Angelo di Bari nel bosco del Sovero si saranno verificati degli eventi rimasti ignoti per la mancanza di fonti documentarie. Solo a partire dal 1175 nel bosco del Sovero abbiamo la presenza di una "ecclesia Sancte Marie de Suberito" e nel 1203 di due comunità monastiche e in seguito di un hospitale. Nel bosco del Sovero il ritrovamento (o invenzione) in un anfratto carsico della antichissima icona, la Theotokos (Madre di Dio), la Hodighitria(Colei che indica la via), per la mancanza di supporti documentali certi, viene riportato all'XI secolo. Esperti iconografi hanno attestato che l' icona sia opera di qualche monaco eremita collegato a una tradizione artistica locale di derivazione greco orientale, sviluppatasi nell'Italia Meridionale. Ci troviamo di fronte a una tempera su tavola di ciliegio dai tratti tipicamente bizantineggianti(cm.45 di altezza e cm.36,5 di larghezza) la cui genesi potrebbe essere rapportata anteriormente al 1175 che vede la presenza della ecclesia Sancte Marie de Suberito. L'Icona di proprietà del Capitolo Concattedrale venne incoronata dal Vescovo, di venerata memoria, Achille Salvucci per delega e decreto del Capitolo Vaticano il 17 gennaio 1965.Nel 1974 ha subito un restauro conservativo ad opera del prof. Cesare Giulio Franco della Soprintendenza di Bari, il quale mise in campo per il delicato lavoro le tecniche più avanzate del momento in fatto di restauro, riportate dall'arciprete Cipriani in un dettagliato "giornale del restauro". L'immagine originaria della icona venne fuori dopo l'esame ai raggi X.I restauri conservativi e della icona nel 1974 e del tempietto d'argento nel 1980 furono realizzati grazie all'alta professionalità, all'impegno, alla passione, al devoto amore per la Vergine di Sovereto profusi dall'arciprete curato don Michele Cipriani, dal Soprintendente prof. Michele D'Elia e dal prof. Cesare Giulio Franco. Nel 2025 si è reso necessario, dopo cinquant'anni, una ulteriore ricognizione dello stato di salute della icona in quanto presentava rigonfiamenti del velo pittorico. I lavori di restauro, sempre conservativi, sono iniziati dopo le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza di Belle Arti di Bari e dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali. L'immagine della Vergine è stata sottoposta ad accurate indagini ed interventi, portati a termine da parte del restauratore Valentino de Sario di Oria. Dai raggi X sono riemerse le immagini originarie della Vergine e del Bambino. La Vergine presenta intorno al capo aureola gialla con bordi rossi (nimbo), sul capo e sulle spalle un maphorion con orlature d'oro , di color porpora in origine(simbolo di santità e di regalità); il Bambino aureola gialla e bordi rossi intorno al capo, benedice alla greca con la mano destra (l'anulare unito al pollice, incontro tra la natura umana e la natura divina in Cristo) e con la sinistra sembra, dall'esame dei raggi X, che reggesse in origine l'Evangelo invece del globo crucigero(segno del potere di Cristo(la croce) sul mondo(la sfera).Quasi certamente il globo fu inserito durante i primi restauri subiti dall'icona verso la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento ad opera del canonico Gioacchino de Paù(1749-1833)che ridipinse integralmente la tavola facendo perdere i suoi connotati originari ritornati solo con il restauro del 1974 nella versione iconografica della Vergine Hodighitria che chiaramente esprime due dogmi di fede: il dogma della divinità del Bambino Gesù(Colui che è la Via) e il dogma della divina maternità della Vergine(Theotokos) che con il braccio sinistro sorregge il Bambino benedicente e con la destra lo indica al popolo. Nel XVIII secolo si risveglia nel popolo l'antico culto verso la Vergine soveretana, assurta a compatrona insieme al patrono San Michele Arcangelo. La devozione verso una Madre dai straordinari poteri taumaturgici viene incrementata nei primi decenni del Settecento da un pio ecclesiastico, il canonico Francesco Bonaduce. Partecipa fattivamente a questa esplosione religiosa anche l'Università che con l'assenso dell'arciprete Giovannangelo Pantaleo, tra il 1700 e il 1713, fece costruire nella Collegiata di Sant'Angelo una nuova cappella dedicata alla Vergine di Sovereto che presentava un altare di marmi colorati e su di esso facevano bella figura anche le statue di S. Sebastiano e S. Rocco coprotettori della città. Anche il popolo per rendere concreta e visibile la sua devozione a proprie spese fece sostituire, tra il 1717 e il 1719, la cona lignea che custodiva la venerata immagine con una custodia o "macchina" d'argento commissionata a Napoli e realizzata dall'argentiere Antonio Torrone. L'icona, purtroppo, per un errore effettuato nel rilevamento delle misure non si adattò alla incorniciatura del tempietto in argento massiccio cesellato per cui fu deciso di mutilarla di alcuni centimetri. Anche la teca argentea dopo una accurata indagine effettuata dal restauratore dell'icona prof. Cesare Franco, ha subito il primo restauro nei primi mesi del 1980 in un laboratorio di Bari ad opera del maestro argentiere Domenico De Scisciolo. Il restauro del 2025 della "macchina" d'argento si è reso necessario per far fronte ai gravi deterioramenti che aveva subito negli ultimi cinquant'anni. Le relative operazioni sono state effettuate dai dottori Giuseppe Tritto e Marianna Cerfeda nel loro laboratorio di Lecce. Il racconto del ritrovamento dell'icona in una grotta del bosco del Sovero ha certamente un suo connotato storico da riferirsi a un periodo anteriore ai documenti già esaminati (1131-1172-1175).Ciò dimostra che su quella grotta sia sorta inizialmente una cappellina trasformata in ecclesia citata dal documento del 1175 nel quale un certo Elia alla presenza di testimoni detta le sue disposizioni pro anima, concedendo cinquanta ducali alla "ecclesia sancte Marie de Suberito" che era diventata e per le donazioni e per i lasciti che vi convogliavano e per la devozione dei terlizzesi verso la sacra immagine punto strategico di riferimento religioso. Di questa ecclesia per mancanza di testimonianze documentarie non abbiamo un'idea delle sue caratteristiche in quanto l'unica testimonianza rimasta è l'abside con monofora a spina di pesce e semi- cupola a copertura di chiancarelle, preziosa reliquia del Romanico pugliese, visibile l'esterno nel retrostante giardino, l'interno nella attuale chiesa coperto dal dossale d'altare in legno proveniente dalla "ecclesia Sancte Marie de Circitano" e trasportato nel 1725 a Sovereto con la relativa icona dell'Hodighitria su disposizione del visitatore apostolico fra'Antonio Pacecco da Frosolone(Isernia),vescovo Minore Conventuale di Bisceglie. L'intero vano absidale presenta un affresco raffigurante il Cristo Pantocrator (l'Onnipotente) con apostoli che alcuni storici dell'Arte lo datano allo stesso periodo della ecclesia. I superstiti elementi strutturali dell'abside dimostrano che la primitiva ecclesia certamente è databile intorno ai primi decenni del secolo XII .Un documento di estrema importanza datato "1203 maggio, Terlizzi" riportato dal medievalista Giosuè Musca nel suo studio "Una famiglia di boni homines nella Terlizzi normanna e sveva", è la chiara testimonianza della presenza nel Sovero di due comunità religiose, una maschile e una femminile, insediatesi molto prima accanto alla ecclesia Sancte Marie de Suberito. La comunità femminile aveva in dotazione una piccola chiesetta dedicata all'evangelista San Marco per cui le religiose venivano chiamate le monache di San Marco; la comunità maschile apparteneva a un ordine cavalleresco. Ma quale? Al riguardo le opinioni degli storici sono diverse. Testimonianze documentarie, epigrafiche, scultoree dimostrano la presenza nel Sovero sin dagli ultimi decenni del XII sec. e inizio del XIII dell'Ordine cavalleresco di San Giovanni di Gerusalemme, contestata da alcuni studiosi di storia di Ordini cavallereschi che invece vedono anche la presenza dell'Ordine Teutonico e dei Templari. Ma la carta del 1203, in assenza di altri documenti similari, dimostra che la comunità maschile che operava a Sovereto apparteneva, senza alcun dubbio, all'Ordine religioso e cavalleresco dei "Fratelli Ospedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme" ed aveva in gestione anche una domus hospitalis di cui parla una carta terlizzese del 1199 che rappresenta una ulteriore testimonianza insieme a quella del 1203 della presenza gerosolimitana. La tradizione orale tramandataci dal popolo e l'analisi critica della realtà documentaria confermano quanto affermato. L'Ordine fu fondato intorno alla prima metà dell'XI secolo, forse nel 1048,a Gerusalemme e messo sotto la protezione di San Giovanni Battista. Seguiva prima la regola di San Benedetto, in seguito quella di Sant'Agostino. Nel 1113 fu approvato dal papa Pasquale II. Conventi ed ospedali dell'Ordine si diffusero nei punti strategici di città e di vie attraversate da pellegrini diretti in Terrasanta. Il citato documento del 1203 ci presenta la famiglia de Spastrica della civitas Terlitii. Alla morte del capofamiglia, il vecchio Russolo, Gemma la moglie non desidera andare ad abitare presso la nipote Gerbina ma entrare nel monastero di Suberito a poca distanza dalla civitas. Nel documento troviamo termini come "abbatissa ecclesie Sancte Marie de Suberito" e "sorores" che ci fanno pensare a monache che con il loro "velamen nigrum" fossero di osservanza benedettina. C'è anche da dire che in quel monastero abbiamo anche donne qualificate come oblate che collaboravano con le claustrali nell'assistenza, come la nobildonna Gemma vedova di Russolo de Spastrica che aveva offerto se stessa e i suoi beni patrimoniali al monastero. Nel negozio giuridico in esame di cui l'abbatissa è l'autrice, si parla anche di una comunità religiosa maschile guidata da un prior e composta di fratres e oblati. L'atto giuridico alla fine viene firmato anche da un presbiter prior, un prestiber oblatus e un oblatus, gerarchia chiaramente di una comunità operante in convento-ospedale che nel nostro caso era alle dipendenze del convento-hospitale del Priorato di Barletta. Di questa dipendenza ne parla il documento n.181 del CDB,III, datato 1199.Un certo Giovenale, terlizzese, fa testamento lasciando erede dei suoi beni la figlia Giaquinta, la quale in caso di mancanza di eredi una parte dei beni donati dovrà darla all'hospitale di Barletta . Il Gran Priorato di Barletta che aveva sotto la sua giurisdizione il territorio del Regno di Sicilia citra Farum, non poteva non prendere in considerazione nella sua espansione una zona, come quella del Sovero con la sua ecclesia Sancte Marie de Suberito, attraversata dalla via consolare Appia, arteria strategica di passaggio di pellegrini e crociati verso la Terrasanta oltre che di pastori degli Abruzzi che sver navano con le loro greggi lungo l'altopiano carsico murgiano i cui ultimi rilievi si innervano lungo la via Appia-Traiana nelle cui vicinanze, verso Bitonto, il convento hospitale e la chiesa santuario dei Gerosolimitani rappresentavano i luoghi ove trovare sollievo e accoglienza e venerare la "Madonna dell'acqua" uno dei titoli dato alla Vergine soveretana di cui i pastori erano molto devoti. Il Prior del convento-hospitale di Sovereto era il legittimo rappresentante del Gran Priore di Barletta affiancato nella gestione da "fratres" e da "oblati" generalmente laici donatori. L'intero complesso soveretano (il convento, l'hospitale ,la chiesa santuario) che prese la denominazione di Precettoria, col passar del tempo vede accrescere il proprio patrimonio grazie a donazioni. L'esercizio del culto, l'assistenza e la vita di comunità venivano gestiti dai praeceptores . Nel santuario è possibile ammirare tre lastre sepolcrali con epigrafi latine di praeceptores di fine sec.XIII e inizio XIV. Una di queste riporta il nome del praeceptor fra' Ramondo de Bolera. E' interessante parlare a questo punto anche di una epigrafe riportata dallo storico De Giacò nella sua opera "Il santuario di Soverito in Terlizzi", andata perduta e posta sulla facciata della chiesetta di S. Marco che ci porterebbe ad ipotizzare la presenza a Sovereto di un monasterium duplex, antica istituzione altomedievale, costituito da due comunità distinte(maschile e femminile) e diretto da una badessa. Ipotesi questa tutta da studiare. Nel tempo l'hospitale di Sovereto è stato oggetto di donazioni come quella di Giovenale riportata nella carta del 1199 e quella del vescovo di Canne, Arturio. Nel documento del 1244 Arturio cede all' "hospitale Sancti Iohannis Ierosolimitani" di Barletta la chiesa- monastero di Santa Maria de Mari sulla foce dell'Ofanto vicino Barletta e relative proprietà, perchè rimasta senza monache, e la chiesa di Ciurcitano in loco Terlitii che successivamente passerà in dotazione alla Precettoria di Sovereto. I praeceptores cercarono di aumentare il patrimonio anche con l'acquisto di terre. Due strumenti notarili datati 1219 e 1247 di cui parla il De Giacò nella citata opera testimoniano questa volontà. Da ultimo l'Università di Terlizzi con istrumento del 1294, riportato sempre dal De Giacò, acquista il bosco di S. Maria di Soverito per formare una adeguata dote per le necessità dell'hospitale e per far godere ai cittadini gli usi civici di legnare e pascolare. I beni posseduti dalla domus hospitalis di Sovereto erano riportati nelle Collettorie della Camera Apostolica ed esenti dalle decime, tassazioni imposte dal papa i cui proventi servivano a finanziare la difesa della Terra Santa .Il patrimonio posseduto dalla Precettoria registrata nelle Collettorie con la denominazione "hospitale Sancti Iohannis" era abbastanza consistente e si arricchirà in seguito con le proprietà del bosco e chiesa di S. Eugenia. Trattandosi di un patrimonio di un Ordine religioso cavalleresco, la normativa canonica impediva ai vescovi diocesani di mettervi il naso. All'inizio del XVI secolo avvenimenti politici e religiosi provocano il declino della Precettoria di Sovereto. L'Impero Ottomano conquista Gerusalemme e la Terra Santa, vittoria che pose fine ai continui pellegrinaggi dei cristiani che nei secoli precedenti avevano attraversato la via Francigena e la consolare Appia Traiana diretti in Terra Santa. La sconfitta cristiana fu una delle cause che provocò l'abbandono dei centri di assistenza per crociati e pellegrini sparsi lungo le suddette vie di transito. La domus praeceptoria, cioè convento hospitale con chiesa santuario di Santa Maria de Suberito si trasforma in Commenda, tipica istituzione degli Ordini cavallereschi che si presentava come concessione data dal Gran Maestro dell'Ordine per decreto a cavalieri vecchi e benemeriti di beni resisi liberi quasi sempre per cessazione delle attività di un convento- ospedale. C'è da dire anche che il monastero femminile delle monache di San Marco cessando la Precettoria è costretto a chiudere. Uno degli ultimi praeceptores pare sia stato "Frater Rubertus De Mirabellis Praeceptor Terlicii Anno D(omini)1475", come si può notare da una lapide posizionata sulla parte interna del portale d'accesso alla corte della chiesa santuario. L'inizio della Commenda di Sovereto è riconducibile agli anni 1516-1517. Si parla della Commenda per la prima volta nel 1538.Una disposizione degli Statuti Municipali di Terlizzi la esentava dal pagamento del dazio sull'olio mosto. La lunga vita di quasi tre secoli della Commenda è scandita però dalla quasi mancanza di testimonianze documentarie. Si possiedono solo gli atti seicenteschi di visite canoniche con i relativi cabrei(elenchi di beni) che ci parlano del racconto dell'invenzione della icona e del patrimonio posseduto. Da citare la visita del 1604 che fu disposta dal Gran Priore di Barletta Ferdinando Gonzaga ed ebbe come visitatori il cavaliere fra' Tarquinio Sansone e il cappellano dell'Ordine di Malta fra' Antonio Salduario che dopo la visita si recarono a Ciurcitano, dipendenza della Commenda. Nel 1619 la visita fu compiuta dal cavaliere fra'Girolamo Marulli e da fra'Santo Trono cappellano conventuale. La presenza di alcuni commendatari a Sovereto è desumibile dai superstiti stemmi lapidei che si ammirano sulle facciate degli antichi edifici. Nel 1516 troviamo come commendatario fra' Carlo Pandone del Priorato di Capua, nel 1579 fra' Filippo Gaeta di Cosenza, già priore di Messina, nel 1586 fra' Gio(vanni) Maria Carmignano de Napoli Com(m)endatore de Molfecta et Terlizzo. Altri assegnatari della Commenda in ordine sono stati : fra 'Nicola Maria Tresca, patrizio barese del quale si conservano tre lapidi che riportano il suo nome, due sono visibili sulla torre costruita negli anni 1603-1604 e una sulla sua casa (1610); fra'Giovanni Battista Gadaleta patrizio tranese, ricordato da una lapide sulla facciata della chiesa -santuario( 1669); fra' Giovanni Antonio Ilderis, patrizio bitontino(1725); fra' Marco Geronda dei baroni di Canneto e patrizio barese, già Gran Priore di Messina(1760),il quale dette disposizioni al notaio terlizzese Nicola de Fiore di compilare il Cabreo della Commenda di Sovereto, un inventario di tutte le proprietà fondiarie della Commenda( tenuta macchiosa, santuario, chiesetta di San Marco e la domus hospitalis) redatto negli anni 1762-1769 e al quale collaborò l'agrimensore Ignazio Scolamacchia. Il cabreo riporta i latifondi del Sovero(100 vigne coltivate e 534 di terre macchiose), il bosco Sant'Eugenia ( 615 vigne) ed altre proprietà affittate o concesse a censo. Inoltre, è arricchito da una raffigurazione del patrimonio della Commenda curata dall'agrimensore Giuseppe de Bernardi(1732). La precaria situazione della Puglia nei primi decenni del Cinquecento, attraversata da eserciti francesi e spagnoli ,spinse i commendatari intorno al 1570 ad affidare al Capitolo della Collegiata di Sant'Angelo l'icona che ritornava a Sovereto il 23 di aprile, rimanendo per otto giorni durante i quali veniva effettuata la fiera mercato di San Marco(dal 23 aprile al 1° maggio) istituita dai frati ospedalieri di San Giovanni e confermata da privilegio angioino. Terminata la fiera, l'icona ritornava a Terlizzi nella Collegiata romanico gotica e veniva posizionata nella seconda cappella della navata laterale destra che era dotata di altare dichiarato privilegiato da papa Gregorio XIII con Breve del 1° giugno 1581.La traslazione della sacra immagine trova la sua conferma nelle visite pastorali fatte a Terlizzi il 1598 e il 1607 dai vescovi giovinazzesi Antonio Viperano e Gregorio Santacroce, i quali vengono a conoscenza dell'origine e delle vicende della icona, in particolare della contesa tra terlizzesi e bitontini per il suo possesso. Dopo oltre tre secoli di vita della Commenda il patrimonio del complesso soveretano fu incamerato al demanio dal Regime francese con decreto del 5 novembre 1808 e in seguito messo all'asta e venduto a privati. Il terlizzese Michele Lamparelli(1776-1857), medico di corte fedele ai francesi, acquistò il bosco denominato Sovero, fondi rustici e urbani e gli antichi stabili soveretani(chiesa-convento-ospedale-monastero) con istrumento del 18 gennaio 1812 e 1 giugno 1813 del notaio Emanuele Caputi di Napoli. Invece il bosco di Sant'Eugenia fu venduto ai nobili Siciliani di Giovinazzo. Tornato nella sua amata Terlizzi, il Lamparelli, medico della Regina Carolina Annunziata, consorte di Gioacchino Murat e sorella di Napoleone, si fece massaro come amava dire di sè e nella solitudine del Sovero trasformò, grazie alle sue conoscenze agronomiche e al duro lavoro dei nostri esperti contadini, un paesaggio di rara bellezza, quale era il bosco del Sovero, in mandorleti e in argentei uliveti. Alla sua morte i fondi rustici e urbani e gli antichi stabili soveretani furono ereditati dal nipote Giuseppe Lamparelli che apportò a tutta proprietà ricevuta consistenti modifiche e nel 1878 quale patrono della chiesa procedette al restauro dell'interno. La famiglia Lamparelli ha mantenuto il possesso e il patronato sulla chiesa e sue pertinenze fino al 1939, acquisiti dalla famiglia di Vincenzo Tamborra nel 1940.La famiglia Tamborra-Vendola di recente con atto notarile ha donato la chiesa santuario alla Diocesi di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi e venduto alla stessa le relative pertinenze necessarie per il culto.
Inno alla Madonna di Sovereto
Ritornello:
Proteggi il popolo
che in Te confida
salva i Tuoi figli
Santa Maria
Santa Maria di Sovereto,
la nostra terra scegliesti tu
a illuminare di nuova luce,
mostraci il figlio e fuggiranno
le tenebre del mondo,
dolce Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Vergine Santa, stringi al petto
il Figlio Tuo e a noi ripeti:
tutta fate la sua Parola.
Rischiara il nostro cammino,
sostieni la speranza,
Santa Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Tu d'ogni uomo sei l'aiuto
da sempre, guarda le amarezze
che ci affliggon, in Te fidiamo:
lo sguardo volgerai ai miseri
e pregherai il Figlio,
pia Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Madre T'ha fatta Cristo in croce,
benigna accoglici e forma Tu,
con lo Spirito, in ogni uomo
il volto di Gesù Tuo figlio
e nasceremo nuovi,
Ave Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Al Padre, Dio onnipotente
per Cristo, Figlio e nostro fratello
nel Santo Spirito Consolatore
salga perenne onore e gloria
dalla tua Chiesa unita,
Trinità Santa.
Rit. Proteggi il popolo…
Fonti documentarie:
C.D.B.,III, Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi(971-1300),a cura di F. Carabellese, Bari 1899
C.D.B.,II, Le pergamene del Duomo di Bari(1266-1309),a cura di G.B. Nitto De Rossi e F. Nitti Di Vito, Bari 1899
C.D.P., XXII, Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi(1266-1381),a cura di F. Magistrale, Bari 1976
Bibliografia:
De Giacò P., "Il santuario di Soverito in Terlizzi", Bari 1872
Amico A.(P. Rosario, capp.),Fitostoria descrittiva della provincia di Bari, Firenze 1955
Musca G., Una famiglia di "boni homines" nella Terlizzi normanna e sveva, in ASP,XXI(1968)
Valente G., Feudalesimo e feudatari in sette secoli di storia di in Comune pugliese(Terlizzi 1073-1779) I, Periodo normanno(1071-1194),Molfetta1982;II Periodo Svevo(1194-1266),Molfetta 1983;Periodo Angioino(1266-1435),Molfetta1985
Valente G., La Madonna di Sovereto e il Carro Trionfale, Molfetta 1994
Dott. Bernardi Vito -Studioso della Puglia e di Terlizzi
Parlare di Sovereto significa inserire questo lembo di terra nell'ambito del paesaggio naturale terlizzese che nel corso dei millenni ha subito una radicale trasformazione a causa di eventi di natura geologica e climatica. Con il Neolitico il territorio si trasforma, presentandosi dolcemente poggiante sulla fascia media murgiana, ondulato e ricoperto di macchia mediterranea e con un clima salubre per la vicinanza al mare. Un territorio che sul principio del secolo VIII assumerà un carattere ben definito, tipicamente militare e agricolo secondo lo schema romano germanico. Il Chronicon Monasterii Cassinensis di Leone Ostiense(Vescovo Cardinale di Ostia,1060 circa-1115) parla di un "casale… in Trelicio" che si affaccia alla storia quale possedimento longobardo nel 773, inserito nell'ambito della circoscrizione territoriale di Giovinazzo. La relativa testimonianza documentale è costituita da un atto di donazione del casale, avvenuta probabilmente tra il 778 e il 797, da parte di un gastaldo longobardo del Ducato di Benevento di nome Wacco a beneficio del monastero di Montecassino. Intorno alla metà del sec. XI si affacciano nel Meridione i Normanni con i quali nasce e si consolida il feudalesimo. Troviamo i normanni nel locus Tillizo intorno al 1040 con il terzogenito di Tancredi d'Altavilla, Umfredo, il quale ricostruisce in loco Cisani una chiesa fatiscente(1055).Con il primo feudatario di Terlizzi, il conte Amico, il locus Tillizo acquista autonomia civile ed ecclesiastica dalla vicina Giovinazzo, trasformandosi in castrum con mura, torri, castello, chiesa matrice di S. Angelo e nel 1133 in "civitas Terlitii", aggregata da Ruggero II "rex Siciliae atque Italiae" alla contea di Conversano. Con Guglielmo II, detto il Buono(1166-1189), Terlizzi ritorna contea assumendo una propria identità politica, sociale, economica e religiosa. Nel 1189 Guglielmo II muore e indica suo successore Enrico VI di Svevia. Inizia la monarchia sveva. Nel 1197 muore Enrico VI e lascia erede il figlio Federico II. Federico affida Terlizzi ad Andrea , logoteta del regno di Sicilia, che amplia le fortificazioni attorno la città, potenzia il castello normanno e contribuisce alla costruzione dell'antico duomo romanico gotico. I documenti medievali conservati nel nostro Archivio Capitolare ci aprono orizzonti per comprendere il rapporto simbiotico che intercorre tra il lembo di terra del boscoso Sovero e le vicende politiche e umane della civitas Terlitii che dalla fine del sec. XI fino al XIII costruirà la sua storia feudale rimasta tale fino al sec. XVIII. Suberitum , piccola località poco distante dalla civitas, assunta alle cronache della notorietà per avvenimenti di natura religiosa e sociale ivi avvenuti, in passato era ricoperta da un bosco ricco di querce della varietà suberosa che uno studioso di botanica, il francescano cappuccino Antonio Amico, in religione Padre Rosario, la individua nell' "Ulmus campestris". Difatti osserva: "Può darsi che la varietas suberosa fosse anticamente frammista alla specie tipica e che dal popolo venisse chiamata sughero(suber)". Il documento più antico che parla del bosco di Santa Maria di Sovereto, denominato anche bosco di San Marco o Parco Forte, è del 1183.Nel 1294 l'Università' di Terlizzi lo acquistò e dette la possibilità ai propri cittadini di legnare e pascolare e quindi di godere degli usi civici su quelle terre in perpetuo. Il toponimo Suberitum per la prima volta viene citato nella bolla dell'arcivescovo Angelo di Bari del 1131 il quale concedeva pieni poteri giurisdizionali al vescovo Ursone su Giovinazzo e Terlizzi e relative pertinenze, fra cui Suberitum. Un 'altra Bolla del 1172, dell'arcivescovo Rainaldo di Bari, rinnovava al vescovo Berto di Giovinazzo antichi e nuovi privilegi:"(…)cum omnibus monasteriis virorum seu feminarum, grecis aut latinis, intus in civitatem(…)vel de foris". Antichi e nuovi privilegi si riferivano agli insediamenti urbani o monastici con una ecclesia sui quali si esercitavano poteri giurisdizionali. Prima della bolla del 1131 dell'arcivescovo Angelo di Bari nel bosco del Sovero si saranno verificati degli eventi rimasti ignoti per la mancanza di fonti documentarie. Solo a partire dal 1175 nel bosco del Sovero abbiamo la presenza di una "ecclesia Sancte Marie de Suberito" e nel 1203 di due comunità monastiche e in seguito di un hospitale. Nel bosco del Sovero il ritrovamento (o invenzione) in un anfratto carsico della antichissima icona, la Theotokos (Madre di Dio), la Hodighitria(Colei che indica la via), per la mancanza di supporti documentali certi, viene riportato all'XI secolo. Esperti iconografi hanno attestato che l' icona sia opera di qualche monaco eremita collegato a una tradizione artistica locale di derivazione greco orientale, sviluppatasi nell'Italia Meridionale. Ci troviamo di fronte a una tempera su tavola di ciliegio dai tratti tipicamente bizantineggianti(cm.45 di altezza e cm.36,5 di larghezza) la cui genesi potrebbe essere rapportata anteriormente al 1175 che vede la presenza della ecclesia Sancte Marie de Suberito. L'Icona di proprietà del Capitolo Concattedrale venne incoronata dal Vescovo, di venerata memoria, Achille Salvucci per delega e decreto del Capitolo Vaticano il 17 gennaio 1965.Nel 1974 ha subito un restauro conservativo ad opera del prof. Cesare Giulio Franco della Soprintendenza di Bari, il quale mise in campo per il delicato lavoro le tecniche più avanzate del momento in fatto di restauro, riportate dall'arciprete Cipriani in un dettagliato "giornale del restauro". L'immagine originaria della icona venne fuori dopo l'esame ai raggi X.I restauri conservativi e della icona nel 1974 e del tempietto d'argento nel 1980 furono realizzati grazie all'alta professionalità, all'impegno, alla passione, al devoto amore per la Vergine di Sovereto profusi dall'arciprete curato don Michele Cipriani, dal Soprintendente prof. Michele D'Elia e dal prof. Cesare Giulio Franco. Nel 2025 si è reso necessario, dopo cinquant'anni, una ulteriore ricognizione dello stato di salute della icona in quanto presentava rigonfiamenti del velo pittorico. I lavori di restauro, sempre conservativi, sono iniziati dopo le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza di Belle Arti di Bari e dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali. L'immagine della Vergine è stata sottoposta ad accurate indagini ed interventi, portati a termine da parte del restauratore Valentino de Sario di Oria. Dai raggi X sono riemerse le immagini originarie della Vergine e del Bambino. La Vergine presenta intorno al capo aureola gialla con bordi rossi (nimbo), sul capo e sulle spalle un maphorion con orlature d'oro , di color porpora in origine(simbolo di santità e di regalità); il Bambino aureola gialla e bordi rossi intorno al capo, benedice alla greca con la mano destra (l'anulare unito al pollice, incontro tra la natura umana e la natura divina in Cristo) e con la sinistra sembra, dall'esame dei raggi X, che reggesse in origine l'Evangelo invece del globo crucigero(segno del potere di Cristo(la croce) sul mondo(la sfera).Quasi certamente il globo fu inserito durante i primi restauri subiti dall'icona verso la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento ad opera del canonico Gioacchino de Paù(1749-1833)che ridipinse integralmente la tavola facendo perdere i suoi connotati originari ritornati solo con il restauro del 1974 nella versione iconografica della Vergine Hodighitria che chiaramente esprime due dogmi di fede: il dogma della divinità del Bambino Gesù(Colui che è la Via) e il dogma della divina maternità della Vergine(Theotokos) che con il braccio sinistro sorregge il Bambino benedicente e con la destra lo indica al popolo. Nel XVIII secolo si risveglia nel popolo l'antico culto verso la Vergine soveretana, assurta a compatrona insieme al patrono San Michele Arcangelo. La devozione verso una Madre dai straordinari poteri taumaturgici viene incrementata nei primi decenni del Settecento da un pio ecclesiastico, il canonico Francesco Bonaduce. Partecipa fattivamente a questa esplosione religiosa anche l'Università che con l'assenso dell'arciprete Giovannangelo Pantaleo, tra il 1700 e il 1713, fece costruire nella Collegiata di Sant'Angelo una nuova cappella dedicata alla Vergine di Sovereto che presentava un altare di marmi colorati e su di esso facevano bella figura anche le statue di S. Sebastiano e S. Rocco coprotettori della città. Anche il popolo per rendere concreta e visibile la sua devozione a proprie spese fece sostituire, tra il 1717 e il 1719, la cona lignea che custodiva la venerata immagine con una custodia o "macchina" d'argento commissionata a Napoli e realizzata dall'argentiere Antonio Torrone. L'icona, purtroppo, per un errore effettuato nel rilevamento delle misure non si adattò alla incorniciatura del tempietto in argento massiccio cesellato per cui fu deciso di mutilarla di alcuni centimetri. Anche la teca argentea dopo una accurata indagine effettuata dal restauratore dell'icona prof. Cesare Franco, ha subito il primo restauro nei primi mesi del 1980 in un laboratorio di Bari ad opera del maestro argentiere Domenico De Scisciolo. Il restauro del 2025 della "macchina" d'argento si è reso necessario per far fronte ai gravi deterioramenti che aveva subito negli ultimi cinquant'anni. Le relative operazioni sono state effettuate dai dottori Giuseppe Tritto e Marianna Cerfeda nel loro laboratorio di Lecce. Il racconto del ritrovamento dell'icona in una grotta del bosco del Sovero ha certamente un suo connotato storico da riferirsi a un periodo anteriore ai documenti già esaminati (1131-1172-1175).Ciò dimostra che su quella grotta sia sorta inizialmente una cappellina trasformata in ecclesia citata dal documento del 1175 nel quale un certo Elia alla presenza di testimoni detta le sue disposizioni pro anima, concedendo cinquanta ducali alla "ecclesia sancte Marie de Suberito" che era diventata e per le donazioni e per i lasciti che vi convogliavano e per la devozione dei terlizzesi verso la sacra immagine punto strategico di riferimento religioso. Di questa ecclesia per mancanza di testimonianze documentarie non abbiamo un'idea delle sue caratteristiche in quanto l'unica testimonianza rimasta è l'abside con monofora a spina di pesce e semi- cupola a copertura di chiancarelle, preziosa reliquia del Romanico pugliese, visibile l'esterno nel retrostante giardino, l'interno nella attuale chiesa coperto dal dossale d'altare in legno proveniente dalla "ecclesia Sancte Marie de Circitano" e trasportato nel 1725 a Sovereto con la relativa icona dell'Hodighitria su disposizione del visitatore apostolico fra'Antonio Pacecco da Frosolone(Isernia),vescovo Minore Conventuale di Bisceglie. L'intero vano absidale presenta un affresco raffigurante il Cristo Pantocrator (l'Onnipotente) con apostoli che alcuni storici dell'Arte lo datano allo stesso periodo della ecclesia. I superstiti elementi strutturali dell'abside dimostrano che la primitiva ecclesia certamente è databile intorno ai primi decenni del secolo XII .Un documento di estrema importanza datato "1203 maggio, Terlizzi" riportato dal medievalista Giosuè Musca nel suo studio "Una famiglia di boni homines nella Terlizzi normanna e sveva", è la chiara testimonianza della presenza nel Sovero di due comunità religiose, una maschile e una femminile, insediatesi molto prima accanto alla ecclesia Sancte Marie de Suberito. La comunità femminile aveva in dotazione una piccola chiesetta dedicata all'evangelista San Marco per cui le religiose venivano chiamate le monache di San Marco; la comunità maschile apparteneva a un ordine cavalleresco. Ma quale? Al riguardo le opinioni degli storici sono diverse. Testimonianze documentarie, epigrafiche, scultoree dimostrano la presenza nel Sovero sin dagli ultimi decenni del XII sec. e inizio del XIII dell'Ordine cavalleresco di San Giovanni di Gerusalemme, contestata da alcuni studiosi di storia di Ordini cavallereschi che invece vedono anche la presenza dell'Ordine Teutonico e dei Templari. Ma la carta del 1203, in assenza di altri documenti similari, dimostra che la comunità maschile che operava a Sovereto apparteneva, senza alcun dubbio, all'Ordine religioso e cavalleresco dei "Fratelli Ospedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme" ed aveva in gestione anche una domus hospitalis di cui parla una carta terlizzese del 1199 che rappresenta una ulteriore testimonianza insieme a quella del 1203 della presenza gerosolimitana. La tradizione orale tramandataci dal popolo e l'analisi critica della realtà documentaria confermano quanto affermato. L'Ordine fu fondato intorno alla prima metà dell'XI secolo, forse nel 1048,a Gerusalemme e messo sotto la protezione di San Giovanni Battista. Seguiva prima la regola di San Benedetto, in seguito quella di Sant'Agostino. Nel 1113 fu approvato dal papa Pasquale II. Conventi ed ospedali dell'Ordine si diffusero nei punti strategici di città e di vie attraversate da pellegrini diretti in Terrasanta. Il citato documento del 1203 ci presenta la famiglia de Spastrica della civitas Terlitii. Alla morte del capofamiglia, il vecchio Russolo, Gemma la moglie non desidera andare ad abitare presso la nipote Gerbina ma entrare nel monastero di Suberito a poca distanza dalla civitas. Nel documento troviamo termini come "abbatissa ecclesie Sancte Marie de Suberito" e "sorores" che ci fanno pensare a monache che con il loro "velamen nigrum" fossero di osservanza benedettina. C'è anche da dire che in quel monastero abbiamo anche donne qualificate come oblate che collaboravano con le claustrali nell'assistenza, come la nobildonna Gemma vedova di Russolo de Spastrica che aveva offerto se stessa e i suoi beni patrimoniali al monastero. Nel negozio giuridico in esame di cui l'abbatissa è l'autrice, si parla anche di una comunità religiosa maschile guidata da un prior e composta di fratres e oblati. L'atto giuridico alla fine viene firmato anche da un presbiter prior, un prestiber oblatus e un oblatus, gerarchia chiaramente di una comunità operante in convento-ospedale che nel nostro caso era alle dipendenze del convento-hospitale del Priorato di Barletta. Di questa dipendenza ne parla il documento n.181 del CDB,III, datato 1199.Un certo Giovenale, terlizzese, fa testamento lasciando erede dei suoi beni la figlia Giaquinta, la quale in caso di mancanza di eredi una parte dei beni donati dovrà darla all'hospitale di Barletta . Il Gran Priorato di Barletta che aveva sotto la sua giurisdizione il territorio del Regno di Sicilia citra Farum, non poteva non prendere in considerazione nella sua espansione una zona, come quella del Sovero con la sua ecclesia Sancte Marie de Suberito, attraversata dalla via consolare Appia, arteria strategica di passaggio di pellegrini e crociati verso la Terrasanta oltre che di pastori degli Abruzzi che sver navano con le loro greggi lungo l'altopiano carsico murgiano i cui ultimi rilievi si innervano lungo la via Appia-Traiana nelle cui vicinanze, verso Bitonto, il convento hospitale e la chiesa santuario dei Gerosolimitani rappresentavano i luoghi ove trovare sollievo e accoglienza e venerare la "Madonna dell'acqua" uno dei titoli dato alla Vergine soveretana di cui i pastori erano molto devoti. Il Prior del convento-hospitale di Sovereto era il legittimo rappresentante del Gran Priore di Barletta affiancato nella gestione da "fratres" e da "oblati" generalmente laici donatori. L'intero complesso soveretano (il convento, l'hospitale ,la chiesa santuario) che prese la denominazione di Precettoria, col passar del tempo vede accrescere il proprio patrimonio grazie a donazioni. L'esercizio del culto, l'assistenza e la vita di comunità venivano gestiti dai praeceptores . Nel santuario è possibile ammirare tre lastre sepolcrali con epigrafi latine di praeceptores di fine sec.XIII e inizio XIV. Una di queste riporta il nome del praeceptor fra' Ramondo de Bolera. E' interessante parlare a questo punto anche di una epigrafe riportata dallo storico De Giacò nella sua opera "Il santuario di Soverito in Terlizzi", andata perduta e posta sulla facciata della chiesetta di S. Marco che ci porterebbe ad ipotizzare la presenza a Sovereto di un monasterium duplex, antica istituzione altomedievale, costituito da due comunità distinte(maschile e femminile) e diretto da una badessa. Ipotesi questa tutta da studiare. Nel tempo l'hospitale di Sovereto è stato oggetto di donazioni come quella di Giovenale riportata nella carta del 1199 e quella del vescovo di Canne, Arturio. Nel documento del 1244 Arturio cede all' "hospitale Sancti Iohannis Ierosolimitani" di Barletta la chiesa- monastero di Santa Maria de Mari sulla foce dell'Ofanto vicino Barletta e relative proprietà, perchè rimasta senza monache, e la chiesa di Ciurcitano in loco Terlitii che successivamente passerà in dotazione alla Precettoria di Sovereto. I praeceptores cercarono di aumentare il patrimonio anche con l'acquisto di terre. Due strumenti notarili datati 1219 e 1247 di cui parla il De Giacò nella citata opera testimoniano questa volontà. Da ultimo l'Università di Terlizzi con istrumento del 1294, riportato sempre dal De Giacò, acquista il bosco di S. Maria di Soverito per formare una adeguata dote per le necessità dell'hospitale e per far godere ai cittadini gli usi civici di legnare e pascolare. I beni posseduti dalla domus hospitalis di Sovereto erano riportati nelle Collettorie della Camera Apostolica ed esenti dalle decime, tassazioni imposte dal papa i cui proventi servivano a finanziare la difesa della Terra Santa .Il patrimonio posseduto dalla Precettoria registrata nelle Collettorie con la denominazione "hospitale Sancti Iohannis" era abbastanza consistente e si arricchirà in seguito con le proprietà del bosco e chiesa di S. Eugenia. Trattandosi di un patrimonio di un Ordine religioso cavalleresco, la normativa canonica impediva ai vescovi diocesani di mettervi il naso. All'inizio del XVI secolo avvenimenti politici e religiosi provocano il declino della Precettoria di Sovereto. L'Impero Ottomano conquista Gerusalemme e la Terra Santa, vittoria che pose fine ai continui pellegrinaggi dei cristiani che nei secoli precedenti avevano attraversato la via Francigena e la consolare Appia Traiana diretti in Terra Santa. La sconfitta cristiana fu una delle cause che provocò l'abbandono dei centri di assistenza per crociati e pellegrini sparsi lungo le suddette vie di transito. La domus praeceptoria, cioè convento hospitale con chiesa santuario di Santa Maria de Suberito si trasforma in Commenda, tipica istituzione degli Ordini cavallereschi che si presentava come concessione data dal Gran Maestro dell'Ordine per decreto a cavalieri vecchi e benemeriti di beni resisi liberi quasi sempre per cessazione delle attività di un convento- ospedale. C'è da dire anche che il monastero femminile delle monache di San Marco cessando la Precettoria è costretto a chiudere. Uno degli ultimi praeceptores pare sia stato "Frater Rubertus De Mirabellis Praeceptor Terlicii Anno D(omini)1475", come si può notare da una lapide posizionata sulla parte interna del portale d'accesso alla corte della chiesa santuario. L'inizio della Commenda di Sovereto è riconducibile agli anni 1516-1517. Si parla della Commenda per la prima volta nel 1538.Una disposizione degli Statuti Municipali di Terlizzi la esentava dal pagamento del dazio sull'olio mosto. La lunga vita di quasi tre secoli della Commenda è scandita però dalla quasi mancanza di testimonianze documentarie. Si possiedono solo gli atti seicenteschi di visite canoniche con i relativi cabrei(elenchi di beni) che ci parlano del racconto dell'invenzione della icona e del patrimonio posseduto. Da citare la visita del 1604 che fu disposta dal Gran Priore di Barletta Ferdinando Gonzaga ed ebbe come visitatori il cavaliere fra' Tarquinio Sansone e il cappellano dell'Ordine di Malta fra' Antonio Salduario che dopo la visita si recarono a Ciurcitano, dipendenza della Commenda. Nel 1619 la visita fu compiuta dal cavaliere fra'Girolamo Marulli e da fra'Santo Trono cappellano conventuale. La presenza di alcuni commendatari a Sovereto è desumibile dai superstiti stemmi lapidei che si ammirano sulle facciate degli antichi edifici. Nel 1516 troviamo come commendatario fra' Carlo Pandone del Priorato di Capua, nel 1579 fra' Filippo Gaeta di Cosenza, già priore di Messina, nel 1586 fra' Gio(vanni) Maria Carmignano de Napoli Com(m)endatore de Molfecta et Terlizzo. Altri assegnatari della Commenda in ordine sono stati : fra 'Nicola Maria Tresca, patrizio barese del quale si conservano tre lapidi che riportano il suo nome, due sono visibili sulla torre costruita negli anni 1603-1604 e una sulla sua casa (1610); fra'Giovanni Battista Gadaleta patrizio tranese, ricordato da una lapide sulla facciata della chiesa -santuario( 1669); fra' Giovanni Antonio Ilderis, patrizio bitontino(1725); fra' Marco Geronda dei baroni di Canneto e patrizio barese, già Gran Priore di Messina(1760),il quale dette disposizioni al notaio terlizzese Nicola de Fiore di compilare il Cabreo della Commenda di Sovereto, un inventario di tutte le proprietà fondiarie della Commenda( tenuta macchiosa, santuario, chiesetta di San Marco e la domus hospitalis) redatto negli anni 1762-1769 e al quale collaborò l'agrimensore Ignazio Scolamacchia. Il cabreo riporta i latifondi del Sovero(100 vigne coltivate e 534 di terre macchiose), il bosco Sant'Eugenia ( 615 vigne) ed altre proprietà affittate o concesse a censo. Inoltre, è arricchito da una raffigurazione del patrimonio della Commenda curata dall'agrimensore Giuseppe de Bernardi(1732). La precaria situazione della Puglia nei primi decenni del Cinquecento, attraversata da eserciti francesi e spagnoli ,spinse i commendatari intorno al 1570 ad affidare al Capitolo della Collegiata di Sant'Angelo l'icona che ritornava a Sovereto il 23 di aprile, rimanendo per otto giorni durante i quali veniva effettuata la fiera mercato di San Marco(dal 23 aprile al 1° maggio) istituita dai frati ospedalieri di San Giovanni e confermata da privilegio angioino. Terminata la fiera, l'icona ritornava a Terlizzi nella Collegiata romanico gotica e veniva posizionata nella seconda cappella della navata laterale destra che era dotata di altare dichiarato privilegiato da papa Gregorio XIII con Breve del 1° giugno 1581.La traslazione della sacra immagine trova la sua conferma nelle visite pastorali fatte a Terlizzi il 1598 e il 1607 dai vescovi giovinazzesi Antonio Viperano e Gregorio Santacroce, i quali vengono a conoscenza dell'origine e delle vicende della icona, in particolare della contesa tra terlizzesi e bitontini per il suo possesso. Dopo oltre tre secoli di vita della Commenda il patrimonio del complesso soveretano fu incamerato al demanio dal Regime francese con decreto del 5 novembre 1808 e in seguito messo all'asta e venduto a privati. Il terlizzese Michele Lamparelli(1776-1857), medico di corte fedele ai francesi, acquistò il bosco denominato Sovero, fondi rustici e urbani e gli antichi stabili soveretani(chiesa-convento-ospedale-monastero) con istrumento del 18 gennaio 1812 e 1 giugno 1813 del notaio Emanuele Caputi di Napoli. Invece il bosco di Sant'Eugenia fu venduto ai nobili Siciliani di Giovinazzo. Tornato nella sua amata Terlizzi, il Lamparelli, medico della Regina Carolina Annunziata, consorte di Gioacchino Murat e sorella di Napoleone, si fece massaro come amava dire di sè e nella solitudine del Sovero trasformò, grazie alle sue conoscenze agronomiche e al duro lavoro dei nostri esperti contadini, un paesaggio di rara bellezza, quale era il bosco del Sovero, in mandorleti e in argentei uliveti. Alla sua morte i fondi rustici e urbani e gli antichi stabili soveretani furono ereditati dal nipote Giuseppe Lamparelli che apportò a tutta proprietà ricevuta consistenti modifiche e nel 1878 quale patrono della chiesa procedette al restauro dell'interno. La famiglia Lamparelli ha mantenuto il possesso e il patronato sulla chiesa e sue pertinenze fino al 1939, acquisiti dalla famiglia di Vincenzo Tamborra nel 1940.La famiglia Tamborra-Vendola di recente con atto notarile ha donato la chiesa santuario alla Diocesi di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi e venduto alla stessa le relative pertinenze necessarie per il culto.
Inno alla Madonna di Sovereto
Ritornello:
Proteggi il popolo
che in Te confida
salva i Tuoi figli
Santa Maria
Santa Maria di Sovereto,
la nostra terra scegliesti tu
a illuminare di nuova luce,
mostraci il figlio e fuggiranno
le tenebre del mondo,
dolce Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Vergine Santa, stringi al petto
il Figlio Tuo e a noi ripeti:
tutta fate la sua Parola.
Rischiara il nostro cammino,
sostieni la speranza,
Santa Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Tu d'ogni uomo sei l'aiuto
da sempre, guarda le amarezze
che ci affliggon, in Te fidiamo:
lo sguardo volgerai ai miseri
e pregherai il Figlio,
pia Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Madre T'ha fatta Cristo in croce,
benigna accoglici e forma Tu,
con lo Spirito, in ogni uomo
il volto di Gesù Tuo figlio
e nasceremo nuovi,
Ave Maria.
Rit. Proteggi il popolo…
Al Padre, Dio onnipotente
per Cristo, Figlio e nostro fratello
nel Santo Spirito Consolatore
salga perenne onore e gloria
dalla tua Chiesa unita,
Trinità Santa.
Rit. Proteggi il popolo…
Fonti documentarie:
C.D.B.,III, Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi(971-1300),a cura di F. Carabellese, Bari 1899
C.D.B.,II, Le pergamene del Duomo di Bari(1266-1309),a cura di G.B. Nitto De Rossi e F. Nitti Di Vito, Bari 1899
C.D.P., XXII, Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi(1266-1381),a cura di F. Magistrale, Bari 1976
Bibliografia:
De Giacò P., "Il santuario di Soverito in Terlizzi", Bari 1872
Amico A.(P. Rosario, capp.),Fitostoria descrittiva della provincia di Bari, Firenze 1955
Musca G., Una famiglia di "boni homines" nella Terlizzi normanna e sveva, in ASP,XXI(1968)
Valente G., Feudalesimo e feudatari in sette secoli di storia di in Comune pugliese(Terlizzi 1073-1779) I, Periodo normanno(1071-1194),Molfetta1982;II Periodo Svevo(1194-1266),Molfetta 1983;Periodo Angioino(1266-1435),Molfetta1985
Valente G., La Madonna di Sovereto e il Carro Trionfale, Molfetta 1994
Dott. Bernardi Vito -Studioso della Puglia e di Terlizzi



.jpg)


.jpg)




 Ricevi aggiornamenti e contenuti da Terlizzi
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Terlizzi 
.jpg)
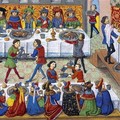

.jpg)

.jpg)






.jpg)

